Il momento in cui un visitatore clicca su “Aggiungi al carrello” segna un passaggio fondamentale nel percorso d’acquisto. Se da un lato questo clic rappresenta un segnale positivo, perché indica la volontà di acquistare, dall’altro rivela che l’utente non ha ancora completato il pagamento. È un passaggio delicato: si è vicini alla meta, ma basta un dettaglio mal funzionante, un percorso poco chiaro o un’informazione mancante per interrompere tutto e perdere la vendita. La costruzione e la gestione del carrello in un e-commerce è quindi un tassello strategico, spesso sottovalutato.
Molte piattaforme offrono un carrello standard integrato, ma esistono diverse modalità di presentarlo all’utente: si passa dal carrello classico su pagina dedicata a soluzioni più dinamiche come il “drawer cart” (carrello a cassetto), i mini cart e i modal cart, fino ad arrivare all’opzione più diretta di tutte: saltare del tutto il carrello portando immediatamente al checkout. Ciascuna soluzione ha le sue peculiarità, i suoi pro e i suoi contro, e non necessariamente esiste un’opzione universale valida per tutti i negozi online.
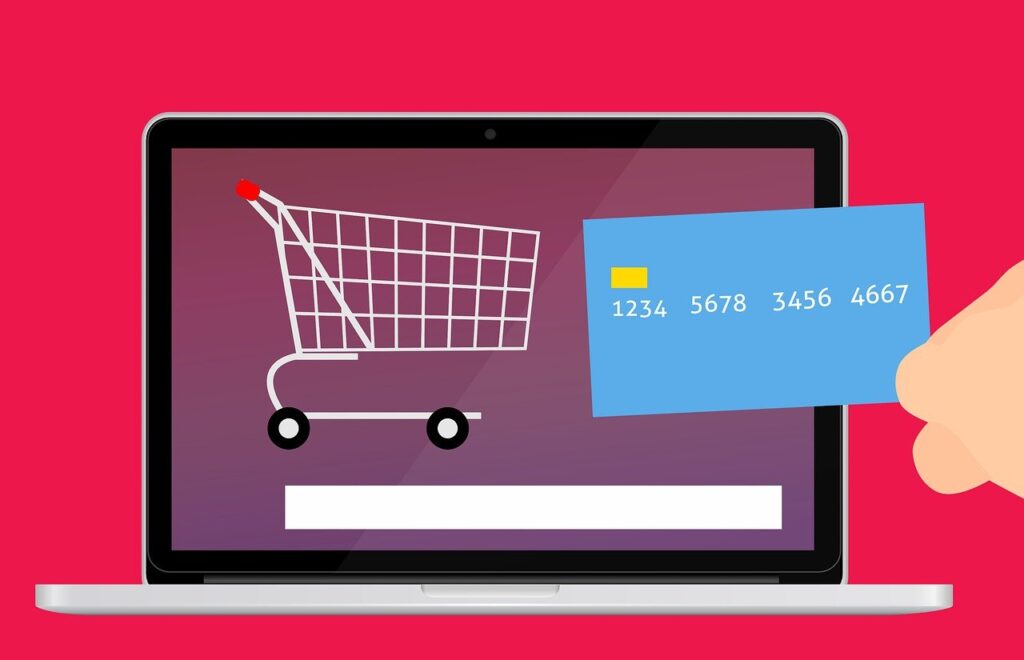
In questa guida pratica, divisa in sezioni, esploreremo in modo approfondito le varie tipologie di carrello, i criteri di scelta e le potenziali ottimizzazioni da applicare. L’obiettivo è offrire una visione completa, toccando sia gli aspetti tecnici sia quelli di user experience, così da facilitare una decisione consapevole su come strutturare il carrello o, in alcuni casi, se eliminarlo del tutto e passare direttamente al checkout.
La funzione psicologica del carrello nel percorso d’acquisto
Dare per scontato che l’utente, una volta aggiunto qualcosa al carrello, completi il pagamento, è un errore comune. Il carrello non è solo un contenitore di prodotti, ma anche uno spazio mentale: quando le persone riempiono un carrello virtuale, stanno dicendo “Questi articoli mi interessano,” ma non sempre “Li comprerò ora.” A volte è un “ripensiamoci dopo,” in altri casi è un “confrontiamo i prezzi,” in altri ancora è un “aggiungo più articoli e poi decido cosa lasciare.”
Per questo, la struttura del carrello deve rassicurare e contemporaneamente guidare con chiarezza. Ogni ulteriore passaggio o informazione non necessaria rischia di far calare la motivazione. Se l’acquirente trova ostacoli come un layout poco intuitivo, troppe domande, costi di spedizione poco chiari o passaggi ridondanti, sale il rischio di abbandono. Da qui si comprende la delicatezza di questo momento: la persona ha espresso un interesse forte, ma non è ancora vincolata in nessun modo.
Panoramica sulle diverse tipologie di carrello
In molte piattaforme e-commerce esistono impostazioni predefinite che gestiscono il carrello in maniera standard, ossia come una pagina dedicata dove l’utente visualizza i prodotti, modifica le quantità o rimuove articoli e poi procede al checkout. Questa formula classica risponde a un’abitudine consolidata e risulta ancora oggi perfettamente funzionale per moltissimi negozi, ma non è l’unica.
Esiste una versione “cassetto” (drawer cart), nella quale il carrello si apre con un effetto scorrevole sul lato della schermata, senza abbandonare la pagina del prodotto. Ne esistono anche versioni dette “mini cart” o “modal cart,” in cui una piccola finestra o un overlay appare sopra la pagina. Infine, c’è la possibilità di saltare completamente l’interfaccia di carrello e indirizzare l’utente direttamente alla fase di checkout (opzione “direct to checkout”).
Ognuno di questi approcci ha razionali distinti. Chi privilegia la massima semplicità e rapidità (specie in negozi che vendono un solo prodotto) preferisce il redirect automatico al checkout. Chi ha un catalogo ampio e widget particolari, come sconti speciali, assicurazioni di spedizione, codici promozionali o sezioni informative obbligatorie, opta spesso per la pagina cart classica. Altri ancora scelgono l’esperienza a cassetto per non interrompere la navigazione: si fa apparire un pannello laterale che consente di vedere subito i prodotti aggiunti e, se si desidera, tornare a sfogliare il negozio.
Nel valutare i diversi metodi, è essenziale comprendere la natura del proprio catalogo (pochi o tanti prodotti, vendite one-shot o multiple, presenza di varianti e così via) e il comportamento tipo dell’utente medio.
Non hai i permessi per visualizzare questa pagina
